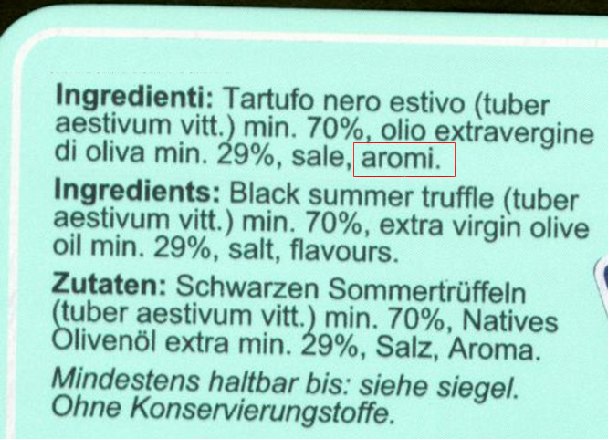Guida: alla “ri”cerca del tartufo scorzone
Guida: alla “ri”cerca del tartufo scorzone
Guida: alla “ri”cerca del tartufo scorzone – Il Tuber aestivum Vittad., ben noto fra i conoscitori di tartufi con l’appellativo volgare di “Scorzone“, il Tuber aestivum si contraddistingue per via di alcune caratteristiche fra cui spiccano le seguenti:
- la gleba color giallo-sporco / nocciola,
- il peridio verrucoso e di colore nero,
- il suo periodo di maturazione, che è quello estivo (da cui trae origine il nome),
è una delle specie meno pregiate nel suo genere, sebbene sia un buon fungo commestibile.
Habitat
In terreni calcarei, drenati e ciottolosi d’origini geologiche diverse con pH 7-8, in boschi di latifoglie e misti, e in rimboscamenti con conifere, ma anche sotto piante isolate, senza prediligere alcun’esposizione, a quote variabili dal livello del mare finora 1400-1600 m. Fruttifica anche in superficie. Solitario o gregario.
Epoca di maturazione
Dalla tarda primavera all’inverno.
Simbiosi in natura con:
| Roverella (Quercus Pubescens)
Leccio Bollato (Quercus Ilex Ballota) Carpino Bianco (Carpinus Betulus) Carpino Nero (Ostrya Carpinifolia) Tiglio Nostrano (Tilia Platyphyllos) Faggio Europeo (Fagus Sylvatica) Betula Verrucosa Populus |
Pino Nero (Pinus Nigra)
Pino Silvestre (Pinus Sylavestris) Pino D’aleppo (Pinus Halepensis) Pinus Brutia Peccio – Abete Rosso (Picea Abies) Simbiosi di sintesi con: Nocciolo di Costantinopoli (Corylus Colurna) |
Corologia
Tra il 37° e il 58° parallelo di latitudine nord.
Portogallo, Spagna, Irlanda, Francia, Gran Bretagna (Scozia compresa), Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Svezia, Lituania, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, repubblica Slovacca Ucraina, Bulgaria, Ungheria, Romania, Serbia, Turchia, Austria, Svizzera,
Italia: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,Basilicata, Sicilia, Sardegna.
Paesi extracomunitari: Marocco, Korea.
Insetti associati
- Leiodes cinnamomea Panzer,
- Agaricopagus cephalotes Schmidt,
- Asiorestia ferruginea Scopoli,
- Colenis immunda Sturm,
- Suillia pallida Fall.
L’ecologia
Studi specifici sull’ecologia del Tuber aestivum sono stati condotti da Chevalier e Frochot (1979, 1988) per le zone della Francia, ma alcune considerazioni possono ritenersi valide anche per l’Italia. Il Tuberastivum è verosimilmente la specie di tartufo commestibile più comune e diffusa in Europa, estendendosi il suo areale dall’Italia e la Spagna fino agli Stati Baltici ed all’U.R.S.S. (Gross, 1975; Chevalier, 1979).
La sua presenza è stata inoltre segnalata nell’Africa del Nord (Fischer, 1938) ed anche nella costa meridionale della Turchia (Zambonelli, 1984). L’enorme area di distribuzione del Tuber aestivum in Europa può spiegarsi con le sue esigenze edafiche e soprattutto climatiche che sono minori di quelle degli altri tartufi pregiati, anche se è difficile sapere in che misura si tratti di Tuber aestivum tipico o della sua varietà “uncinatum”; secondo Chevalier (1978) il Tuber aestivum tipico occupa soprattutto la parte meridionale del suo areale europeo, mentre Tuber aestivum var. “uncinatum” quella orientale (Germania e Paesi dell’Est).
In Italia il Tuber aestivum è presente un po’ ovunque in molte regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino, Veneto) del Centro (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio) e del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Calabria) (Mannozzi e Torini, 1984; Tamburrano, 1988). Il Tuber aestivum è capace di svilupparsi su una grande quantità di terreni formatisi da rocce madri di età geologiche molto differenti: calcari primari del Devoniano, calcari secondari del Trias e del Giuras; calcari terziari dell’Eocene, Oligocene e Miocene; sedimenti eluviali e colluviali del quaternario, con un substrato calcareo che permetta un approvvigionamento in calcio. I suoli a tartufo nero estivo presentano in genere dei profili di tipo rendzina e di tipo suolo bruno calcareo, anche se questo tartufo non teme i suoli molto superficiali, quasi bruti, su roccia madre di calcare duro; la loro tessitura è molto variabile secondo gli ambienti, ma il più sovente si presenta equilibrata.
Il Tuber aestivum può svilupparsi in mezzo alle pietre, fra gli interstizi della roccia o nelle conche, ove si è anche accumulato molto humus proveniente dalla decomposizione delle foglie. Questo tartufo predilige particolarmente terreni calco-magnesiaci, filtranti, ricchi in costituenti fini e grossolani, con struttura aerata e grumosa, e sopporta meglio che il Tuber melanosporum suoli molto più pesanti e tenaci; il tartufo nero d’estate può fruttificare in terreni ricchi d’argilla a condizione che, oltre alla presenza di calcare, la parte superficiale ove si trovano i carpofori sia molto aerata; esso rifugge dai terreni fradici preferendo quelli in cui l’umidità non sia prolungata e che si riasciughino prontamente.
L’aspetto chimico di questi suoli rivela che Tuber aestivum si sviluppa a livelli di sostanza organica molto variabili, tuttavia rispetto al nero pregiato ne sopporta contenuti più elevati, infatti è capace di svilupparsi nella lettiera ammucchiata fra le pietre. La quantità di ioni scambiabili presente nei suoli dove fruttifica lo scorzone può essere variabile, anche se esso si sviluppa generalmente su suoli ben provvisti di potassio ma molto poveri di fosforo e sufficientemente ricchi di calcio. Alcuni recenti risultati mostrano che Tuber aestivum varietà “uncinatum” è capace di fruttificare in suoli che hanno ricevuto una forte concimazione minerale (Chevalier e Frochot, 1988). Il clima gioca un ruolo meno importante nel determinare, rispetto agli altri tartufi pregiati, la distribuzione di T. aestivum che può prosperare in zone con un clima dall’influenza oceanica ma anche in quelle con un clima sensibilmente continentale.
Nei climi di montagna molto spesso T. aestivum rimpiazza il T. melanosporum al di sopra degli 800-1000 m di altitudine, ma al pari di quest’ultimo è esigente riguardo la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni in funzione della temperatura, specialmente durante il periodo di maturazione dei corpi fruttiferi. Secondo De Ferry (1888) buone annate di produzione sono quelle in cui si verificano grosse precipitazioni in giugno, luglio e soprattutto agosto, cioè le annate in cui le messi sono rovinate dalle piogge (Gross, 1975).
Il Tuber aestivum è una specie meno esigente delle altre per quanto riguarda la temperatura, infatti si sviluppa in paesi molto più nordici, si eleva di più in altitudine, ma tollera meno bene la siccità estiva. La vegetazione normalmente associata a questo tartufo è diversa a seconda dei caratteri climatici della zona, così nelle regioni settentrionali, ed in zone meridionali ad altitudine più elevata, il T. aestivum entra in simbiosi di preferenza con farnia (Quercus peduncolata), rovere (Quercus sessiflora), faggio (Fagus silvatica), carpino bianco (Carpinus betulus) e nocciolo (Corylus avellana); in quelle meridionali e in zone settentrionali ad altitudini minori si trova con roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), pino nero (Pinus nigra), pino laricio (Pinus nigra var. laricius) e carpino nero (Ostrya carpinifolia). Secondo Schwarzel (1967) il T. aestivum tipico sarebbe piuttosto associato alle querce ed al nocciolo, mentre Tuber aestivum var. “uncinatum” ai carpini.
Esiste poi una serie di piante che, se pur non direttamente simbionti di questo tartufo, tuttavia si ritrovano comunemente sulle tartufaie come il frassino maggiore (Fraxinus excelsior), l’orniello (Fraxinus ornus), l’acero campestre (Acer campestre), il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyina), la sanguinella (Cornus sanguinea), il sorbo domestico (Sorbus domestica) ed alcune specie di ginepri (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus). Le tartufaie di Tuber aestivum si possono trovare in ambienti molto vari: su bassi versanti e pendici di montagne, su altopiani elevati e nei fondo valle; al margine dei boschi, in prossimità di roveti e di arbusteti, in terreni coltivati, incolti e ricolonizzati da cespuglieti; lungo le strade e sulle scarpate, in pieno bosco e nei rimboschimenti.
Il Tuber aestivum tipico necessita di ambienti soleggiati con un microclima caldo ed un’ombra esattamente dosata (Gross, 1975), invece la sua varietà “uncinatum” sembrerebbe sfuggire le zone troppe esposte ai raggi diseccanti del sole per ritirarsi nelle zone semiombreggiate (Schwarzel, 1967), o addirittura sopportare gli ambienti bui; la varietà “uncinatum” può infatti fruttificare nelle pinete ove non esiste alcuna vegetazione se non i muschi (Chevalier, 1978). La presenza del Tuber aestivum può essere più o meno evidenziata dalle caratteristiche aree prive di vegetazione.
Mentre il Tuber aestivum tipico “brucia” completamente lo strato erbaceo ed i suoi “pianelli” si manifestano in maniera molto netta intorno la pianta ospite, gli indici visuali che permettono di individuare una tartufaia di Tuber aestivum varietà “uncinatum” sono meno netti e le “bruciate” sono meno spettacolari; solo talvolta si osservano delle chiazze o dei circoli presentanti una vegetazione erbacea rachitica e sporadica. Il Tuber aestivum si sviluppa e fruttifica per quasi tutto l’anno, infatti il suo micelio genera più fruttificazioni successive. Il Tuber aestivum tipico forma gli abbozzi dei carpofori a metà febbraio e già a fine aprile, si notano alla superficie del suolo delle screpolature ove emergono i primi tartufi; sollevando i ciuffi secchi di erba si scoprono dei veri e propri nidi di tartufi. Questa prima produzione di maggio-giugno, da cui l’appellativo di “maggengo”, fornisce dei tartufi poco profumati che si degradano facilmente e non sono mai completamente maturi. Il grosso della fruttificazione con carpofori dalle buone caratteristiche organolettiche si ha da agosto a settembre, a condizione tuttavia che vi sia stata qualche precipitazione estiva, altrimenti in luglio la crescita si arresta e i tartufi ancora presenti in terra si seccano o muoiono rapidamente.
Piante comari – Un elemento legato alla maggior parte delle aree di vocazione tartufigene è la presenza di specie arbustive, che non formano ectomicorrizie. Queste sono considerate “piante indicatrici” o “comari” in quanto necessitano di condizioni podologiche e micro ambientali identiche a quelle del tartufo.
Fra gli arbusti, vi sono una miriade di piante, che vivono in prossimità del simbionte tipico e sono ad esso strettamente collegate nell’eco-ambiente dei tartufi:
ROSA CANINA:
Questa pianta deve il nome canina a Plinio il vecchio, che affermava che un soldato romano fu guarito dalla rabbia con un decotto di radici.
È l’antenata delle rose coltivate.
La forma biologica di questa pianta è NP – nano-fanerofita, cioè pianta legnosa con gemme svernanti poste tra i 30 cm e i 2 metri dal suolo.
È un arbusto spinoso, alto 100 – 300 cm, con fusti legnosi glabri, spesso arcuati e pendenti, e radiciprofonde. Le spine rosse sono robuste, arcuate, a base allungata e compressa lateralmente. Le foglie, caduche, sono composte da 5-7 foglioline di 9-25 x 13-40 mm, ovali o ellittiche, con 17-22 denti sul margine. Hanno stipole lanceolate di 3 x 15 mm. I fiori, singoli o a 2-3, hanno un diametro di 4-7 cm e sono poco profumati. Hanno un peduncolo di 20-25 mm e sono generalmente superati dalle foglie. I sepali laciniati, lunghi da 15 a 18 mm, dopo la fioritura si piegano all’indietro e cadono in breve tempo. La corolla è formata grandi petali bilobi, rosati soprattutto sui lobi, di 19-25 x 20-25 mm. Gli stili, lanosi e allungati, sono fusi insieme in una colonnina cilindrica. La rosa canina fiorisce da maggio a luglio. I suoi frutti (di 1-2 cm) carnosi e colorati di un rosso vivace (cinorroidi) raggiungono la maturazione nel tardo autunno. Il suo habitat sono le boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi, fino ad una quota di 1900 m. Preferisce suoli abbastanza profondi, limosi e moderatamente aridi.
GINEPRO COMUNE:
Juniperus communis L. noto come Ginepro comune è un arbusto ramoso o alberetto sempreverde, alto da 1 a 10 m, con foglie lineari-aghiformi, pungenti, riunite in verticilli di 3. La pianta è dioica con piccole infiorescenze, quelle maschili sono piccoli coni ovoidali di colore giallastro, quelle femminili sono piccoli coni di colore verdastro. I semi maturano nell’autunno successivo all’impollinazione e sono racchiusi in una pseudobacca di colore brunastro chiamata galbulo; squamosa e pruinosa, è composta da 4 squame carnose saldate tra loro contenenti da 1 a 3 semi angolosi ricchi di un olio essenziale aromatico. È un arbusto comune in luoghi aridi, incolti o boschivi fino ad altezze di 2.500 m s.l.m., con alcune sottospecie adattate alle alte quote, dalle caratteristiche bacche aromatiche di colore blu. La coltivazione del ginepro richiede clima temperato, dalle frequenti precipitazioni estive, esposizione in pieno sole o mezz’ombra, e suolo ricco ma sabbioso o carsico. Si moltiplica con la semina o per talea di nuovi getti in primavera.
GINESTRA
Le Genisteae sono una tribù di piante appartenenti alla famiglia delle Faboideae. Con il nome comune generico di ginestra si indicano molte delle specie appartenenti a questa tribù, in particolare molte di quelle appartenenti ai generi Calycotome, Chamaecytisus, Cytisus, Genista, Spartium e Ulex.
Le Genisteae sono diffuse in Europa, nel Medio Oriente e in Nord Africa nonché nelle isole della Macaronesia.
Le specie di questa tribù hanno prevalentemente portamento cespuglioso-arbustivo.
CORNUS
I cornioli sono arbusti o piccoli alberi alti fino a 5 m. con foglie ovate ed opposte, ricoperte parzialmente da peluria su entrambe le pagine. I fiori gialli si aprono ad ombrello. I frutti, sia di un bel colore rosso corallo che anche gialli, assomigliano a piccole ciliegie oblunghe. I rami sono di colore rosso-bruno e rametti brevi, la corteccia è screpolata.
Ama terreni umidi ed ombrosi calcarei, per cui è facile trovarlo nei boschi d’alta collina o di montagna.
CILIEGIO SELVATICO
Il ciliegio (Prunus avium) chiamato anche ciliegio degli uccelli o ciliegio selvatico è un albero appartenente alla famiglia delle Rosacee, originario dell’Europa (dalle Isole Britanniche[1] fino alla Russia, passando per Francia, Penisola Iberica, Italia, Germania fino a tutto l’est in zone montuose) e in alcune zone montane fredde dell’Asia minore (presente in scarsa misura con ecotipi leggermente differenti da quelli europei). In Italia è presente naturalmente dalle zone altocollinari sino a quelle montuose, talvolta al confine della zona tipica delle latifoglie, presentando una buona resistenza alfreddo. Assieme al Prunus cerasus esso è una delle due specie di ciliegio selvatico che sono all’origine delle varietà di ciliegio coltivato che produce tipologie di ciliegie che vanno dal graffione bianco piemontese, al Durone nero di Vignola.
PRUNO SPINOSO
Il prugnolo selvatico (Prunus spinosa L.) è un arbusto a foglia caduca della famiglia delle Rosaceae. È alto fino a 4 metri.
I fiori sono bianchi, con frutti tondi di colore blu; le foglie sono obovate, alterne e seghettate.
La fioritura avviene in genere tra marzo e aprile, mentre la maturazione dei frutti tra settembre e ottobre. È una pianta spinosa spontanea dell’Europa, Asia, e Africa settentrionale; cresce ai margini dei boschi e dei sentieri.
FUMANA
La Fumana procumbens è un piccolo arbusto che vegeta nelle zone più basse delle montagne apuane. Non è pianta protetta e diventa molto interessante durante la fioritura.
È un genere di piante che, per lo più, crescono come arbusti in luoghi aridi e su terreni calcarei. Esso comprende una quindicina di specie distinte con circa 60 tra sottospecie, varietà e cultivar.
Esse hanno foglie strette, da ovate-lanceolate a lineari, di solito alterne e di rado opposte. I fiori hanno petali gialli e il frutto è una capsula.
praterie aride, macchie, spiagge su terreno calcareo dal livello del mare fino a 800 metri.
Il Pianello
Alcune specie di tartufo quali T. melanosporum e il T. aestivum hanno la caratteristica di determinare la scomparsa pressoché totale della vegetazione erbacea, annuale o perenne, nelle aree di terreno ove maturano i tartufi, queste aree vengono chiamate “brûlé” in Francia e “pianello” in Italia. Hanno spesso forma circolare, ma possono svilupparsi anche intorno al tronco della pianta tartuficola generando superfici ellittiche, triangolari, ecc. L’area del pianello possiede un’estensione molto variabile, che si accresce con le dimensioni dei capillari radicali della pianta ospite che portano le micorrize, con una tendenza perciò ad espandersi verso l’esterno di 10-15 cm ogni anno Lo sviluppo maggiore delle micorrize si può osservare alla periferia dell’area bruciata o all’esterno della stessa dove è presente la vegetazione erbacea. L’area bruciata si forma per la presenza delle micorrize del tartufo ed anche per l’attività di batteri ed altri funghi micorrizogeni.
I tartufi compaiono prevalentemente all’interno dell’area bruciata, della quale preferiscono la parte più fresca. Il fenomeno dell’area bruciata è stato osservato da tempo tuttavia soltanto da pochi anni si è in grado di capirne le ragioni. In alcuni studi di laboratorio è emersa infatti una chiara azione fitotossica, sulla germinazione dei semi di piante erbacee e sulle giovani piante, originata dagli estratti acquosi di ascocarpi e di filtrati colturali di T. melanosporum coltivato in vitro. Pacioni (1991) ha evidenziato l’influenza negativa di tre aldeidi (2-metilpropanale, 2-metilbutanale e 3-metilbutanale) e due alcoli (2-metilbutanolo e 3-metilbutanolo) estratti da tartufi maturi, sulla germinazione dei semi di alcune piante coltivate e sullo sviluppo di alcuni funghi e batteri della rizosfera.
Fitotossici risultano anche alcuni amminoacidi ed, in generale, alcune sostanze, sia volatili che solubili, dalle quali la terra della tartufaia risulta arricchita in modo tale da impedire o attenuare la germinazione della quasi totalità delle piante erbacee spontanee. La vegetazione caratteristica delle tartufaie naturali è quella tipica di ambienti aperti, secchi e soleggiati, in quanto nelle località con forte piovosità le sostanze fitotossiche sono dilavate ed il pianello è meno evidente. In termini ecologici, la scomparsa delle erbe è giustificata dal fatto che esse sottraggono acqua, necessaria alle micorrize per accrescersi, inoltre ombreggiano il terreno. T. melanosporum è un colonizzatore del pianello molto aggressivo e provvede in modo autonomo a creare la sua nicchia ecologica. La composizione di microfauna e microflora e le loro dinamiche sono molto diverse all’interno ed all’esterno del pianello e cambiano nel corso dello sviluppo di quest’ultimo. effettuarono uno studio i cui risultati confermarono che la presenza di copertura erbacea nell’area esterna al pianello e la presenza di una maggiore quantità di radici stabilizza la struttura del suolo permettendo l’esistenza di aggregati di dimensioni maggiori rispetto a quelli dell’area interna, il cui suolo risulta essere molto più suscettibile agli effetti disgreganti degli agenti meteorici, risultando più incoerente, poroso ed areato. Inoltre la scarsa presenza di copertura erbacea rende il pianello meno ricco in sostanza organica nonché più povero per quanto riguarda le concentrazioni di Fe e Mn.
Il pH dell’area interna al pianello risulta debolmente basico, con valori compresi tra 7.5 e 8.2, e non mostra differenze rilevanti rispetto all’ambiente esterno. Queste osservazioni suggerirono che un terreno maggiormente disgregato ed areato potesse essere una caratteristica favorevole alla crescita del corpo fruttifero del tartufo. Effettuarono ulteriori studi per indagare la natura delle interazioni fra corpi fruttiferi di Tuber, estensione della superficie del pianello e parametri fisico-chimici del suolo. I risultati indicarono che la concentrazione di carbonato attivo all’interno del pianello è significativamente maggiore e l’abbondanza di carbonati totali inferiore rispetto all’esterno del pianello. Le analisi statistiche confermarono che la dimensione dell’area del pianello è correlata con la percentuale di carbonato attivo presente, in quanto spiegava il 51% della variazione di estensione dell’area bruciata. Da questi parametri dedussero che il micelio di T. melanosporum potesse acidificare il suolo nelle immediate vicinanze e solubilizzare differenti frazioni di carbonato all’interno del pianello. L’acidificazione indotta, infatti, provoca lo scioglimento di carbonato di calcio e quindi un aumento del carbonato attivo. L’abbondanza di carbonato attivo provoca un aumento di ioni HCO₃⁻ e Ca²⁺, e ciò porta all’insolubilizzazione di elementi quali Al, Co, Cu, Fe, Zn e Mn. La maggiore concentrazione di carbonato attivo nel suolo del pianello, ad opera delle ife fungine, provoca clorosi nelle piante, che costituisce un sintomo di deficienza alimentare. La clorosi indotta nelle piante competitrici si esplica nell’effetto inibente la crescita e la germinazione, mentre quella che influenza la pianta ospite induce un aumento del bisogno delle risorse trofiche derivate dalla simbiosi micorrizica contratta con il micelio fungino e quindi un aumento della crescita di quest’ultimo, che incrementerà la concentrazione di carbonato attivo nel suolo. Si innesca in questo modo un meccanismo di feedback vantaggioso per il micelio e l’aumento non solo delle sue dimensioni ma anche della produzione di corpi fruttiferi.
Oltre agli studi sull’interazione fra pianello e flora, recentemente ci si è soffermati anche sugli effetti del pianello nella fauna del suolo. È questo il caso di Menta et al. (2014), che è incentrato sul paragone tra comunità di microartropodi all’interno ed all’esterno del pianello di T. aestivum. In questo studio si ipotizza che alcuni gruppi di microartropodi possano essere influenzati negativamente dalla totale assenza di vegetazione all’interno del pianello, mentre altri, quali i collemboli, potrebbero riscontrare condizioni migliori all’interno, in particolare in termini di habitat e risorse trofiche. I risultati di questo studio hanno confermato l’abilità di T. aestivum di modificare le proprietà biochimiche del suolo. Una riduzione dei contenuti organici nel suolo ed un aumento del pH all’interno del pianello, nonché fattori quali la luminosità e la temperatura legate ad una riduzione della copertura erbacea, possono influenzare negativamente la fauna all’interno del pianello. All’interno della famiglia delle Isotomidae tuttavia, il genere Folsomia ha mostrato un’abbondanza superiore all’interno del pianello, lasciando supporre che potrebbe essere attratto dai metaboliti fungini prodotti dal micelio di T. aestivum.
La mosca del tartufo
Un sistema efficace per trovare il “diamante nero”, è quello di cercare la mosca dei tartufi, il cui nome scientifico è Helomyza o Suilla gigantea. Lunga circa un centimetro, rosso bronzo, dalle ali metallizzate, essa ha un odorato così sviluppato, da individuare un tartufo delle dimensioni di un pisello. Ed intorno al tartufo depone le uova, affinché le larve possano cibarsene. Le ore della giornata più favorevoli per cercare le mosche sono quelle centrali, dalle 11 alle 16. Soprattutto se il cielo è coperto o piove leggermente o in caso di nebbia. Al sole i ditteri sono più diffidenti, però il metallo delle loro ali è molto più visibile.Questa tecnica non è consigliabile quando il terreno da esplorare è troppo vasto.